Il potere delle fiabe
- Dott.ssa Danesin Giorgia

- 27 gen 2020
- Tempo di lettura: 4 min
“Mi stavano nella mente come un granello, ci voleva soltanto un soffio di vento, un raggio di sole, una goccia d'erba amara, ed esse sbocciavano” Andersen
Da sempre, storie, leggende e parabole sono i metodi più efficaci per mandare informazioni, insegnare valori e tramandare insegnamenti di vita.
Dalla preistoria, i vecchi tramandavano storie ai giovani; la narrazione è di fatto lo stile di insegnamento universale per condividere lezioni di vita: i maestri più conosciuti al mondo, come Gesù e Buddha, usavano parabole per comunicare un insegnamento di generazione in generazione.
A oggi le fiabe sono ben radicate nella cultura popolare: espressioni come “attenti al lupo” o anche solo l'appellativo di Cenerentola, sono portatori di significati condivisi a livello mondiale. Dai fratelli Grimm ad Andersen, passando per il nostro Gianni Rodari, la letteratura infantile offre una vastissima gamma di storie e fiabe che hanno un enorme potere nello sviluppo del bambino.
I fratelli Grimm iniziarono una raccolta di fiabe con l'originale intento di mettere insieme le testimonianze di una poetica popolare, in precedenza tramandata solo oralmente; solo dopo la pubblicazione della prima edizione, si resero conto che l'opera aveva ricevuto un ampio consenso, oltre che dal pubblico adulto, anche dai bambini. I fratelli tedeschi, di conseguenza, rividero l'opera, riadattandola alle esigenze di un pubblico più giovane. In Danimarca, parallelamente, troviamo Andersen, che da inizio alla creazione di quelle che lui stesso definisce “fiabe... portatrici di pensiero”, fiabe che volgono sempre al bene, pur affrontando tematiche crude e dolorose, come il senso della morte. Luigi Santucci, nel manuale “La letteratura infantile”, afferma che Andersen, nelle sue fiabe, riesce a comunicare ottimismo e la fiducia finale che tutto volga al bene, alla sola condizione di poterselo meritare. Lina Sacchetti scrive: “E la conclusione... è sempre vittoria o premio, meritati per le qualità morali messe in azione dai protagonisti; oppure è punizione per i loro difetti e le loro colpe, spesso con un duplice significato” (“Storia della letteratura per ragazzi”, 1962).
PERCHE' SONO COSI' IMPORTANTI? QUAL E' LA LORO FUNZIONE?
Lo psicologo Michael Yapko sostiene che “i racconti, in quanto strumenti di insegnamento, sono stati il principale mezzo di educazione e socializzazione di tutta la storia umana” (“Trancework: An introduction to the practice of clinical hypnosis”, 2003). Le storie ci insegnano ad affrontare le situazioni che con tutta probabilità incontreremo nel corso della nostra vita e a gestire nel miglior modo le sfide che ci si presentano davanti. Il messaggio che le fiabe mandano è che ognuno di noi si troverà di fronte ad eventi spiacevoli e dolorosi contro i quali dovrà lottare, ma soltanto chi non si tira indietro ma affronta le avversità, potrà uscirne vittorioso. Il bambino ha bisogno di ricevere, in forma simbolica, consigli e suggerimenti su come affrontare questi problemi, arrivando così alla maturità senza difficoltà; nella fiaba viene presentato un dilemma esistenziale, ma in modo chiaro e diretto, in modo tale da farlo cogliere più facilmente al bambino. In ogni fiaba è presente il bene ed il male e queste due dimensioni si incarnano in certi personaggi e nelle loro azioni. Bettelheim afferma che tendenzialmente, l'eroe diventa attraente agli occhi del bambino, il quale tende ad identificarsi con lui, instillando senso morale. Secondo l'autore, il processo di identificazione del bambino non avviene a seguito di una presa di posizione secondo chi è buono e chi no; piuttosto la domanda che il fanciullo si pone è: “Come chi voglio essere?” e, se il personaggio che sceglie è buono, allora anche lui desidererà essere buono. Le fiabe amorali, quelle che non presentano nessun dualismo bene-male, hanno la funzione di costruire il carattere del bambino; queste storie (come nel “Gatto con gli stivali” dove l'eroe si assicura il successo tramite la frode), gli danno la speranza che anche i più umili possono avere successo nella vita; l'obiettivo di queste fiabe, non è instillare il senso della morale, bensì di dare al bambino la fiducia di poter riuscire. La fiaba, dunque, orienta il fanciullo e lo guida nel futuro, aiutandolo a diventare più indipendente.
COME SI NARRA UNA STORIA TERAPEUTICA?
L'abilità di raccontare una storia, si acquisisce con impegno ed esperienza. È importante rendere divertente il racconto, seguire il nostro entusiasmo nella narrazione: in questo modo catturerai l'attenzione del bambino e manterrai un'atmosfera accattivante. È importante adattare la storia alle esigenze del bambino: bisogna comunicare messaggi che lo responsabilizzino e che facilitino il raggiungimento dell'obiettivo terapeutico. L'adattamento della storia deve avvenire anche in base all'età di riferimento: i bambini in età prescolare, è preferibile intrattenerli con i giocattoli, quelli della scuola primaria sono più sensibili alle storie che hanno come protagonisti gli animali, mentre in seguito, si preferisce parlare di eroi. La voce è forse lo strumento più importante per rendere una storia interessante: bisogna scegliere bene lo stile narrativo ed il ritmo, adattando la voce alle azioni che svolgono i personaggi, ma anche alle emozioni che provano. Una buona recitazione prevede anche il regolare il volume della voce a seconda di quello che si sta raccontando. In genere, le storie terapeutiche sono metafore perchè devono parlare al bambino in modo indiretto, immaginativo e devono dargli, in modo implicito, un aiuto nella risoluzione delle proprie difficoltà. Nella pratica clinica, potrei consigliare il manuale “Storie che guariscono” di Georges W. Burns, ed. Erikson, strumento che ritengo molto utile ai fini sopra citati.
Testi consultati:
“Fiabe”, Andersen, edizione Einaudi;
“Il mondo incantato”, Bruno Bettelheim, edizione Feltrinelli;
“Le fiabe dei fratelli Grimm”, Noel Daniel, edizione Taschen;
“Storie che guariscono”, Georges W. Burns, edizione Erikson.



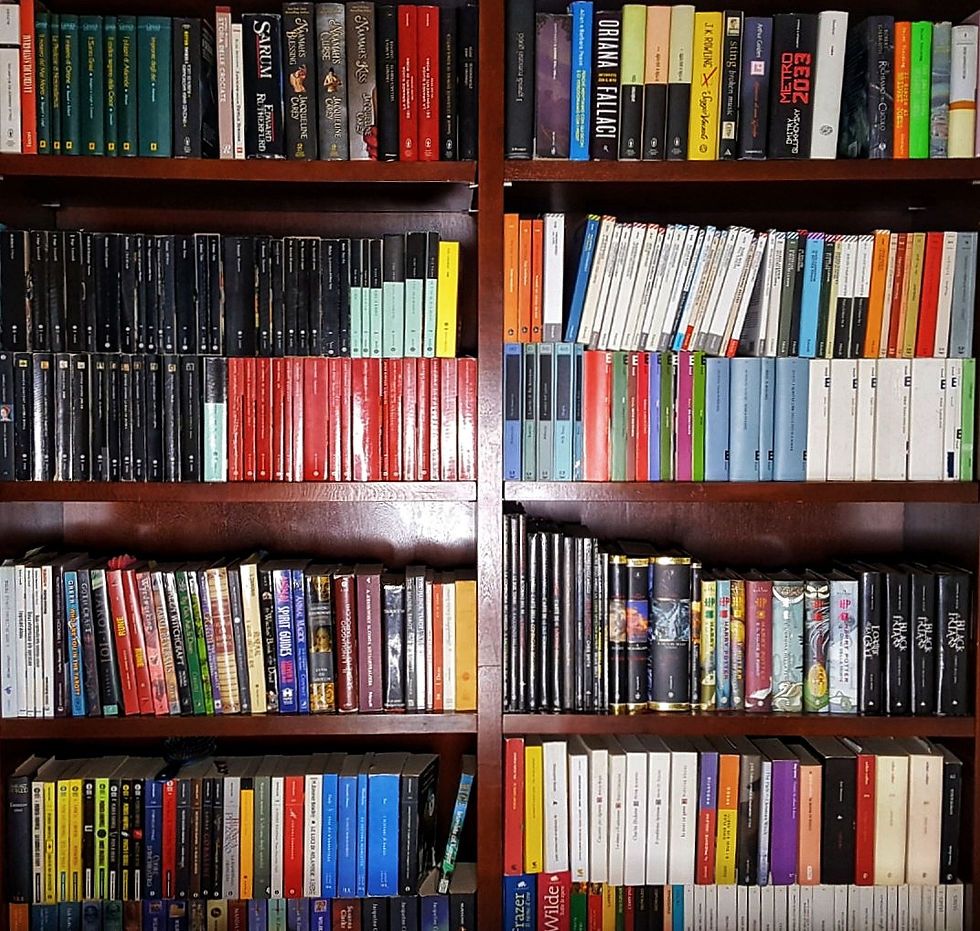
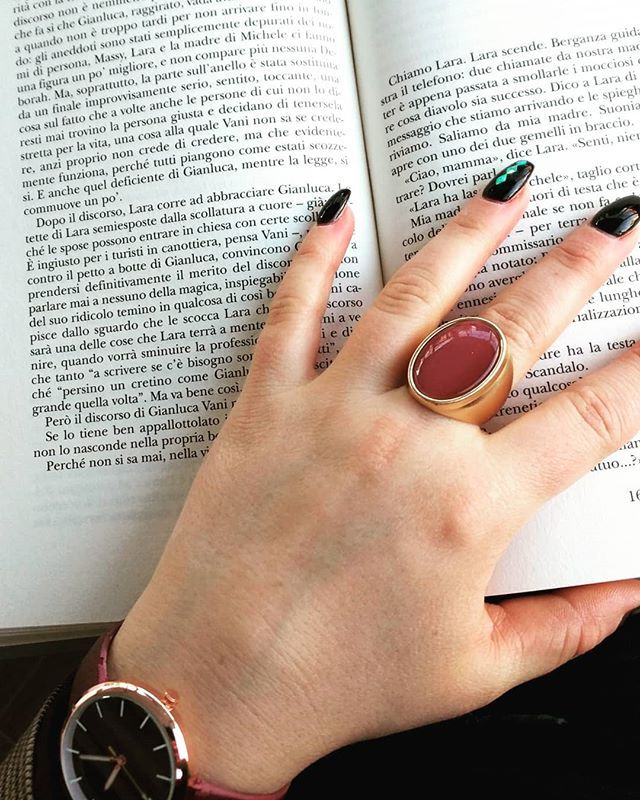
Commenti